- +39 333 9440890
- avv.pollini@studiolegalepollini.it


Ottenere un risarcimento danni dopo un sinistro stradale non è sempre un’impresa facile per la vittima in quanto, come già detto in altro articolo del blog, il danneggiato deve orientarsi tra gli aspetti legati alla
pratica assicurativa e quelli più tecnici e giuridici finalizzati all’accertamento e quantificazione del danno
vero e proprio (danno materiale, lesioni personali, fino al più infausto esito), confrontandosi con la compagnia di assicurazioni che, ponendosi come controparte, muoverà contestazioni dirette tendenzialmente a contenere il risarcimento.
È importante, quindi, per ottimizzare la gestione e le tempistiche della pratica di risarcimento danni dopo un sinistro stradale, affidarsi a uno studio legale che si occupi di infortunistica stradale e che possa consigliare l’avente diritto al risarcimento sin dalla denuncia del sinistro alla assicurazione.
L’Avv. Chiara Pollini svolge l’attività forense in forma autonoma presso il proprio Studio Legale a Vinci – Sovigliana, non lontano dal centro storico della città di Empoli. L’Avv. Chiara Pollini è avvocato civilista con maturata esperienza, tra l’altro, in materia di infortunistica stradale.
Lo Studio Legale fornisce assistenza legale, sia a coloro che, alla guida del proprio mezzo, sono stati vittima di un incidente stradale, sia ai passeggeri trasportati su veicolo altrui coinvolto nell’incidente
stradale, sia a coloro che sono stati investiti come pedoni.

In caso di incidente, dopo aver assicurato i primi soccorsi del caso nei limiti delle proprie possibilità e
capacità ed eventualmente provveduto a chiamare il 118 in caso di dubbio sulle condizioni di salute proprie e delle altre persone coinvolte, è utile chiamare la polizia per i rilievi del caso.
È consigliabile, poi, evitare discussioni sulla dinamica del sinistro ed evitare di confrontarsi su “colpe” dei
conducenti coinvolti, limitandosi allo scambio delle generalità e degli estremi delle polizze.
È sempre utile scattare delle foto del luogo dell’incidente e dei mezzi coinvolti ed è fondamentale farlo
quando la Polizia non venga chiamata, oppure ritardi e si debbano spostare i veicoli perché d’intralcio alla circolazione.

I soggetti coinvolti, conducenti e/o proprietari dei veicoli, dovranno comunicare alla compagnia di
assicurazioni che si è verificato il sinistro (art. 143 Codice della Strada) e ciò avviene, qualora le parti
coinvolte concordino sulla dinamica dell’incidente, tramite il modulo fornito dall’assicurazione medesima:
la “Constatazione Amichevole di Incidente”.
Il modello C.A.I. è sottoscritto con lo scopo di agevolare il disbrigo della pratica da parte della
Assicurazione. Tuttavia, è consigliabile compilare il modulo soltanto se si è assolutamente convinti e certi della dinamica dell’incidente che ivi si deve necessariamente descrivere.
Non è, invece, opportuno sottoscrivere la constatazione in caso si nutrano perplessità sulla ripartizione della responsabilità tra i conducenti dei mezzi coinvolti, perché quanto si è scritto e descritto nel modulo C.A.I. (circostanze e dinamica dell’incidente, conseguenze dell’incidente) ha valenza probatoria tra le parti.
Ciò significa che, in un eventuale giudizio per il risarcimento del danno, quanto dichiarato nella
“Constatazione Amichevole” sarebbe difficilmente superabile (quanto meno) da parte dei soggetti che lo
hanno sottoscritto (conducente/proprietario del veicolo).
A livello normativo, infatti, l’art. 143, comma 2 del Codice Assicurazioni Private prevede che:
“Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.
“I problemi interpretativi sono sorti in merito alla opponibilità di tale dichiarazione all’assicuratore, soggetto diverso dai conducenti che hanno firmato la dichiarazione. In merito sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10311/2006, chiarendo che il modulo C.A.I. a doppia firma, pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore il quale potrà superarla fornendo prova contraria.
Hanno inoltre chiarito che il giudizio debba essere uniforme e unitario per tutte le parti, danneggiato, responsabile e assicuratore, senza che il modulo possa valere in maniera differente tra questi, alla luce dell’art. 2733 c.p.c., comma 3 secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice”.
[Cass. civ. Ordinanza n. 25468/2020].
Considerando la casistica dei giudizi di merito, è pertanto consigliabile compilare e sottoscrivere il C.A.I.
soltanto se la dinamica dell’incidente stradale è chiara per le parti coinvolte, tenendo presente che non vi
alcun obbligo di compilazione del C.A.I..
In caso di dubbio, è invece consigliabile che la denuncia alla compagnia di assicurazioni avvenga con una comunicazione separata, per ciascuno dei mezzi coinvolti nel sinistro, contenente sia la descrizione dell’evento che la richiesta risarcitoria.

Rivolgendosi allo Studio Legale per l’assistenza legale dopo che si è rimasti vittima di un incidente stradale, sarà l’avvocato di fiducia a inoltrare la denuncia danni alla compagnia di assicurazioni, inviando una comunicazione, completa di tutti i documenti e i requisiti di Legge, che aprirà il sinistro con l’assicurazione di riferimento, ottenendo risposta scritta dalla compagnia con i dati necessari per il proseguo della pratica.
A seconda del caso concreto, la denuncia di sinistro stradale con richiesta risarcitoria sarà rivolta dallo
studio legale alla compagnia del danneggiato stesso, oppure alla compagnia della controparte.
La procedura di indennizzo diretto è ormai da lunghi anni in vigore (procedura di liquidazione dei danni
subiti in conseguenza di un sinistro stradale tra due veicoli introdotta con Legge n. 248 del 4 agosto 2006
c.d. Decreto Bersani).
Essa prevede che, in caso di sinistro tra due veicoli dal quale siano derivati danni ai mezzi coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione, anziché alla Compagnia dell’altro veicolo.
La richiesta di risarcimento danni dopo un sinistro stradale alla propria assicurazione può essere presentata per i danni al veicolo, alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato/conducente e per il danno alla persona del conducente, cioè per le lesioni personali riportate a seguito dell’incidente purché si tratti di lesioni di lieve entità (quando i punti percentuali di invalidità sono pari o inferiori a nove).
In caso di lesioni personali superiori a nove punti di invalidità, la domanda risarcitoria sarà inoltrata dalla studio legale prescelto per la consulenza in caso di sinistro, all’Assicurazione dell’altro veicolo, secondo l’iter preesistente la normativa del 2006.

In estrema sintesi, per richiedere il risarcimento danni dopo un sinistro stradale alla propria compagnia di assicurazione devono pertanto ricorrere le seguenti condizioni:

L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento danni dopo un sinistro stradale, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile.
Il danneggiato riceverà una proposta di risarcimento danni e potrà accettarla o, non ritenendola congrua, rifiutarla.
L’utilità dell’assistenza legale in caso di incidente stradale emerge in particolar modo in questa fase della
pratica, dato che affidarsi a uno studio legale che si occupa di infortunistica stradale faciliterà la
negoziazione con le compagnie assicurative, ridurrà i tempi di gestione del sinistro e soprattutto condurrà ad ottenere un risarcimento adeguato ai danni subiti dal proprio cliente, giungendo a un accordo stragiudiziale.
Potrà capitare che l’assicurazione proponga al danneggiato una somma ritenuta non soddisfacente; in
questo caso, il danneggiato ha il diritto di non accettarla e, tramite il proprio avvocato di fiducia, se ve ne
sono fondati presupposti, chiederà l’integrazione motivando la richiesta sulla base delle prove e degli
accertamenti in proprio possesso.
L’impresa di assicurazione, pur a fronte del rifiuto del danneggiato, entro quindici giorni, corrisponde
comunque la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta. La somma in
tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
Soltanto qualora le trattative con le compagnie assicurative non giungano a buon fine, si dovrà valutare
l’opportunità di adire le vie giudiziarie per ottenere il risarcimento adeguato al danno effettivamente
riportato.

Gli avvocati che forniscono consulenza per gli incidenti stradali assistono i propri clienti illustrando le
opzioni legali disponibili per far valere il diritto al risarcimento danni dopo un sinistro stradale nei confronti delle compagnie di assicurazione (aiutano a compilare la documentazione necessaria richiesta dalla assicurazione e a gestire la pratica dalla denuncia del sinistro alla liquidazione) e degli enti previdenziali eventualmente interessati nel caso concreto.
Rivolgersi ad uno studio legale che si occupa di infortunistica stradale sarà un supporto fondamentale per
poter ottenere il risarcimento dei danni pienamente soddisfacente, come previsto dalla legge, sulla base dei costi e delle spese sostenute, sia per il danno alle vetture e/o alle altre cose materiali danneggiate nell’incidente, sia per le lesioni personali, sia per le spese legali resesi necessarie in conseguenza del sinistro stradale.
Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini è a disposizione per consulenza e assistenza in caso di sinistro stradale ai recapiti indicati.
L’articolo su come ottenere il risarcimento danni dopo un sinistro stradale ti è stato utile?
Ti consigliamo di leggere anche gli altri articoli sull’argomento!

Non sai come ottenere il risarcimento danni dopo un incidente stradale? Continua a leggere e troverai le risposte!

L’Avv. Chiara Pollini, avvocato civilista con esperienza maturata in infortunistica stradale, esercita la professione in forma autonoma presso il proprio Studio Legale a Vinci – Sovigliana, nelle vicinanze del centro storico di Empoli.
Lo Studio Legale fornisce assistenza legale, sia a coloro che, alla guida del proprio mezzo, sono rimasti vittima di un incidente stradale, sia ai passeggeri trasportati su veicolo altrui coinvolto nell’incidente stradale, sia a coloro che sono stati investiti come pedoni.
Ottenere un risarcimento danni dopo un sinistro stradale non è sempre un’impresa facile per la vittima in quanto, come già detto in altro articolo del blog, il danneggiato deve orientarsi tra gli aspetti legati alla pratica assicurativa e quelli più tecnici e giuridici finalizzati all’accertamento e quantificazione del danno vero e proprio (danno materiale, lesioni personali, fino al più infausto esito), confrontandosi con la compagnia di assicurazioni che, ponendosi come controparte, muoverà contestazioni dirette tendenzialmente a contenere il risarcimento.
È importante, quindi, per ottimizzare la gestione e le tempistiche della pratica di risarcimento danni, affidarsi a uno studio legale che si occupi di infortunistica stradale e che possa consigliare l’avente diritto al risarcimento sin dalla denuncia del sinistro alla assicurazione.
In caso di incidente, dopo aver assicurato i primi soccorsi del caso, nei limiti delle proprie possibilità e capacità ed eventualmente provveduto a chiamare il 118 in caso di dubbio sulle condizioni di salute proprie e delle altre persone coinvolte, è utile chiamare la polizia per i rilievi del caso.

È consigliabile, poi, evitare discussioni sulla dinamica del sinistro e sulla “colpa” dei conducenti, limitandosi allo scambio delle generalità e degli estremi delle polizze. È sempre utile scattare delle foto del luogo dell’incidente e dei mezzi coinvolti ed è fondamentale farlo quando la Polizia non venga chiamata, oppure ritardi e si debbano spostare i veicoli perché d’intralcio alla circolazione.
I soggetti coinvolti, conducenti e/o proprietari dei veicoli, dovranno comunicare alla compagnia di assicurazioni che si è verificato il sinistro (art. 143 Codice della Strada) e ciò avviene, qualora le parti coinvolte concordino sulla dinamica dell’incidente, tramite il modulo fornito dall’assicurazione medesima: la “Constatazione Amichevole di Incidente”.
Il modello C.A.I. è sottoscritto con lo scopo di agevolare il disbrigo della pratica da parte della Assicurazione. Tuttavia, è consigliabile compilare il modulo soltanto se si è assolutamente convinti e certi della dinamica dell’incidente che ivi si deve necessariamente descrivere. Non è, invece, opportuno sottoscrivere la constatazione in caso si nutrano perplessità sulla ripartizione della responsabilità tra i conducenti dei mezzi coinvolti, perché quanto si è scritto e descritto nel modulo C.A.I. (circostanze e dinamica dell’incidente, conseguenze dell’incidente) ha valenza probatoria tra le parti. Ciò significa che, in un eventuale giudizio per il risarcimento del danno, quanto dichiarato nella “Constatazione Amichevole” sarebbe difficilmente superabile (quanto meno) da parte dei soggetti che lo hanno sottoscritto (conducente/proprietario del veicolo).

A livello normativo, infatti, l’art. 143, comma 2 del Codice Assicurazioni Private prevede che: “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso“.
Considerando la casistica dei giudizi di merito, è pertanto consigliabile compilare e sottoscrivere il C.A.I. soltanto se la dinamica dell’incidente stradale è lineare e chiara per le parti coinvolte, tenendo presente che non vi alcun obbligo di compilazione del C.A.I..
In caso di dubbio, è invece consigliabile che la denuncia alla compagnia di assicurazioni avvenga con una comunicazione separata, per ciascuno dei mezzi coinvolti nel sinistro, contenente sia la descrizione dell’evento che la richiesta risarcitoria.
Si tenga presente che la sottoscrizione del modello CAI non esclude l’utilità di rivolgersi comunque, successivamente, a uno studio legale che si occupi di infortunistica stradale perché la finalità perseguita dall’avvocato civilista nella gestione dei sinistri stradali è quella di fare avere al danneggiato, che ne ha diritto, il giusto e congruo risarcimento di tutti i danni riportati a causa dell’incidente.
Rivolgendosi allo Studio Legale per l’assistenza legale dopo che si è rimasti vittima di un incidente stradale, sarà l’avvocato civilista di Vs. fiducia a inoltrare la denuncia danni alla compagnia di assicurazioni, inviando una comunicazione, completa di tutti i documenti e i requisiti di Legge, che aprirà il sinistro con l’assicurazione di riferimento, ottenendo risposta scritta dalla compagnia con i dati necessari per il proseguo della pratica.
A seconda del caso concreto, la denuncia di sinistro stradale con richiesta risarcitoria sarà rivolta dallo studio legale alla compagnia del danneggiato stesso, oppure alla compagnia della controparte.
La procedura di indennizzo diretto è ormai da lunghi anni in vigore (procedura di liquidazione dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale tra due veicoli introdotta con Legge n. 248 del 4 agosto 2006 c.d. Decreto Bersani). Essa prevede che, in caso di sinistro tra due veicoli dal quale siano derivati danni ai mezzi coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione, anziché alla Compagnia dell’altro veicolo.
La richiesta di risarcimento danni alla propria assicurazione può essere presentata per i danni al veicolo, alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato/conducente e per il danno alla persona del conducente, cioè per le lesioni personali riportate a seguito dell’incidente purché si tratti di lesioni di lieve entità (quando i punti percentuali di invalidità sono pari o inferiori a nove).

In caso di lesioni personali superiori a nove punti di invalidità, la domanda risarcitoria sarà inoltrata dalla studio legale all’Assicurazione dell’altro veicolo, secondo l’iter preesistente la normativa del 2006.
In estrema sintesi, senza voler essere esaustivi, per richiedere il risarcimento danni alla propria compagnia di assicurazione devono ricorrere le seguenti condizioni:
L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile.
Il danneggiato riceverà una proposta di risarcimento e potrà accettarla o, non ritenendola congrua, rifiutarla.
L’utilità dell’assistenza legale in caso di incidente stradale emerge in particolar modo in questa fase della pratica, dato che affidarsi a uno studio legale che si occupa di infortunistica stradale faciliterà la negoziazione con le compagnie assicurative, ridurrà i tempi di gestione del sinistro e soprattutto condurrà ad ottenere un risarcimento adeguato ai danni subiti dal proprio cliente, giungendo a un accordo stragiudiziale.
Potrà capitare che l’assicurazione proponga al danneggiato una somma ritenuta non soddisfacente; in questo caso, il danneggiato ha il diritto di non accettarla e, tramite il proprio avvocato di fiducia, se ve ne sono fondati presupposti, chiederà l’integrazione, motivando la richiesta sulla base delle prove e degli accertamenti in proprio possesso.
L’impresa di assicurazione, pur a fronte del rifiuto del danneggiato, entro quindici giorni, corrisponde comunque la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
Soltanto qualora le trattative con le compagnie assicurative non giungano a buon fine, si dovrà valutare l’opportunità di adire le vie giudiziarie per ottenere il risarcimento adeguato al danno effettivamente riportato.

Rivolgersi ad uno studio legale che si occupa di infortunistica stradale sarà un supporto fondamentale per poter ottenere il ristoro dei danni pienamente soddisfacente, come previsto dalla legge, sulla base dei costi e delle spese sostenute, sia per il danno alle vetture e/o alle altre cose materiali danneggiate nell’incidente, sia per le lesioni personali, sia per le spese legali resesi necessarie in conseguenza del sinistro stradale. Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini è a disposizione per consulenza e assistenza in caso
di sinistro stradale ai recapiti indicati.


L’Avv. Chiara Pollini è avvocato civilista, con consolidata esperienza, tra l’altro, in materia di infortunistica stradale e di risarcimento danni per incidente stradale. L’Avv. Chiara Pollini svolge la propria attività nel proprio Studio Legale a Vinci (Firenze), nella frazione di Sovigliana, non lontano dal centro storico di Empoli.
Nello scongiurato caso che si resti coinvolti in un incidente stradale, è sempre consigliabile rivolgersi a uno studio legale che si occupi di infortunistica stradale e di risarcimento danni per incidente stradale, evitando l’auto-gestione della pratica. La consulenza legale dell’avvocato, in caso di danni conseguenti un sinistro stradale, tutelerà il danneggiato dalla frettolosa accettazione di un risarcimento non adeguato all’effettiva entità e gravità dei danni riportati.
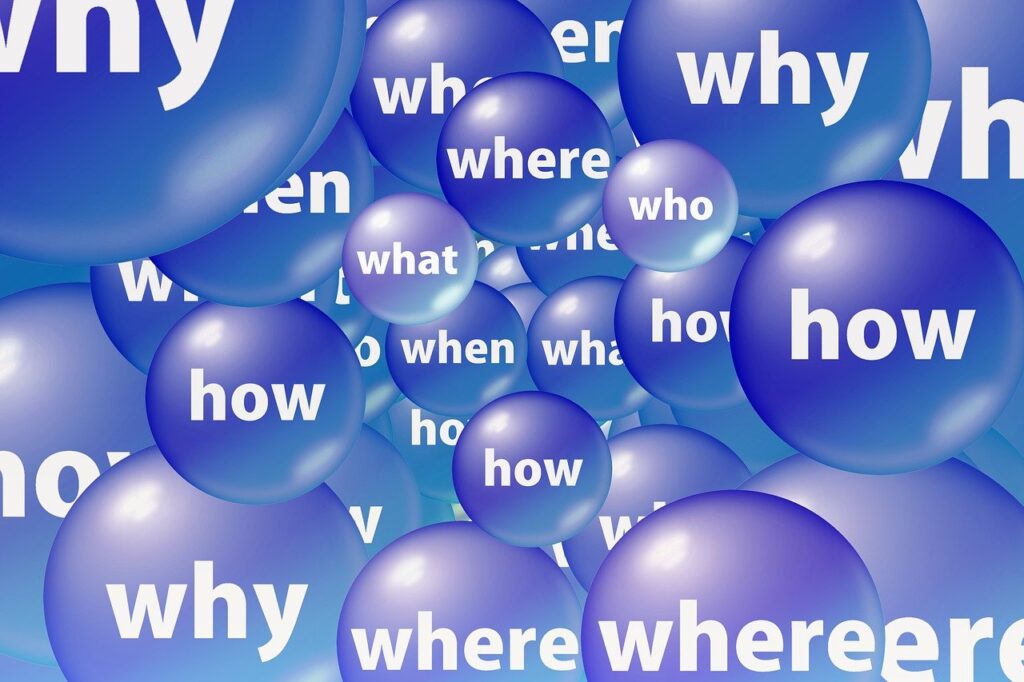
Molteplici danni conseguenti l’incidente stradale: difficoltà comuni nell’auto-gestione della pratica da parte del danneggiato.
I danni conseguenti un incidente stradale possono essere molteplici per cose
e persone (danni materiali, patrimoniali, lesioni personali…) ed è necessario
che essi siano tutti documentati, provati e quantificati alla compagnia di
assicurazione, così da evitare che alcune voci di danno vengano escluse o
comunque diminuite di valore
al momento della quantificazione delle somme che saranno offerte
dall’assicurazione a titolo di risarcimento danni per incidente stradale.
Dunque per la vittima può non essere semplice muoversi tra gli incombenti
tecnici e procedurali della pratica, relazionarsi efficacemente con le
compagnie assicuratrici e i centri liquidazione sinistri.
Infatti, in conseguenza di incidente stradale, se quantificare il danno subito dal mezzo (auto, motociclo o altro) è reso relativamente agevole dal preventivo delle riparazioni che compilerà l’autocarrozzeria, in caso di lesioni personali e/o di morte a seguito del sinistro stradale, la valutazione della congruità della proposta risarcitoria non è altrettanto semplice. Di conseguenza, senza l’assistenza di un avvocato che abbia esperienza nel settore dell’infortunista stradale e del risarcimento danni per incidente stradale, il danneggiato che abbia riportato nell’incidente un danno alla salute, un danno biologico (e/o i parenti di una vittima, nello scongiurato caso di lesioni-decesso in conseguenza dell’incidente) può non essere in grado di capire se il risarcimento danni per incidente stradale offerto dall’assicurazione sia equo e giusto.

Per ottenere il risarcimento danni per incidente stradale, occorre comunicare tempestivamente all’assicurazione l’avvenuto incidente e l’esistenza del veicolo danneggiato e degli ulteriori beni danneggiati, in modo che siano tutti periziati dall’incaricato della compagnia assicurativa al fine di ottenere il risarcimento corrispondente al loro valore di mercato.
Se dal sinistro stradale sono derivati anche lesioni alla persona (o la più grave conseguenza), finalizzare la pratica richiederà tempi più lunghi, sia alla compagnia assicuratrice, che al danneggiato (o ai suoi eredi, in caso di morte come conseguenza del sinistro), dati i più numerosi adempimenti che devono svolgersi; quindi, la trattazione del sinistro richiederà una maggiore diligenza da parte del richiedente il risarcimento danni per incidente stradale.

Anzitutto, occorre seguire il percorso di cura/terapia rivolgendosi a medici qualificati e specialisti. Le spese, sovente anche gravose, che il danneggiato sarà costretto ad anticipare per le cure mediche (farmaci, terapie, visite specialistiche e diagnostiche e quant’altro) saranno, poi, risarcite integralmente dall’assicurazione a condizione che vengano dettagliatamente documentate. Il danneggiato avrà diritto anche alla refusione delle spese per l’assistenza legale.
L’avvocato che assiste la vittima di incidente stradale affianca il danneggiato nella raccolta della documentazione necessaria, parallelamente al percorso di cure e terapie che si renderanno necessarie, sino alla chiusura della malattia i cui postumi, ove esistenti, saranno valutati, nell’interesse del danneggiato, in sede medico legale da medico specialista prescelto dal danneggiato medesimo.
Il danno “fisico”, ovvero il danno alla salute, il danno biologico, verrà indennizzato dalla assicurazione dopo una (successiva seconda) visita medico legale cui la vittima deve sottoporsi presso lo studio medico legale fiduciario della compagnia di assicurazione. L’intervento del medico legale è indispensabile per quantificare i postumi riportati del sinistro stradale (e quindi per quantificare il risarcimento del danno da richiedere alla compagnia di assicurazioni).
Già dall’iter della pratica, qui descritto in estrema sintesi, si comprende quindi, che in caso di lesioni (specialmente in caso di lesioni gravi – gravissime) riportate in un incidente stradale, ricorrere all’assistenza legale di un avvocato che si occupi di infortunistica stradale può fare una sensibile differenza rispetto a dover affrontare la trattazione del sinistro personalmente, senza essere rappresentati dall’avvocato. Affidarsi a un avvocato che si occupa di infortunistica stradale solleva la persona vittima dell’incidente stradale dalle difficoltà gestionali e garantisce che tutta la procedura sia coordinata correttamente e nel rispetto dei tempi previsti per Legge.
Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si occupa, tra l’altro, di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in materia di risarcimento dei danni in caso di incidenti stradali e fornisce la propria consulenza seguendo i propri assistiti lungo tutto l’iter della pratica. Per ogni ulteriore informazione, si invita a contattare lo studio legale ai recapiti indicati.

In questo articolo si esaminano i criteri con cui la legge regolamenta l’affidamento dei figli in caso di separazione e/o divorzio. Per quanto numerosi ed eterogenei siano gli interessi coinvolti nella crisi coniugale, l’interesse dei figli è da sempre considerato prioritario, tanto delle parti in procinto di addivenire alla separazione o al divorzio, quanto dai Giudici chiamati a valutare, in caso di procedimenti contenziosi, le richieste contrapposte dei coniugi/genitori.
L’Avv. Chiara Pollini, nel proprio di Studio Legale a Vinci-Sovigliana, si occupa prevalentemente di diritto civile e di diritto di famiglia e, in questo ambito, ha maturato lunga esperienza anche in materia di separazione e divorzio.

Nel quadro sistematico è assai significativo, in materia di filiazione, che il dettato legislativo non muova dalla mera imposizione di obblighi e/o doveri ai genitori, bensì si declini – dalla prioritaria prospettiva della parte bisognosa di tutela, la prole – riconoscendo i diritti e i fondamentali interessi di cui risultano titolari i figli e che connotano il rapporto di filiazione.
Questa stessa prospettiva è adottata rigorosamente nei Tribunali nell’ambito dei procedimenti in materia di filiazione, separazione e divorzio: l’interesse prevalente, nella vicenda familiare, perseguito dal Giudice è sempre quello dei figli, soprattutto se minorenni: anche se la coppia dei genitori entra in crisi, anche se si guastano i reciproci rapporti e cessa la convivenza tra essi, non mutano i diritti e gli obblighi nei confronti dei figli, né la prospettiva adottata dal Giudicante nella vicenda familiare che muoverà comunque perseguendo il prioritario interesse della prole, come confermato dalle modifiche, anche processuali, introdotte ex D.Lgs. 149/2022 in tal senso.
Per quanto riguarda gli aspetti economici riguardanti la prole, ci si è già occupati, per sommi capi, in altri articoli del blog dell’obbligo di concorrere al mantenimento dei figli che sussiste a carico di entrambi i genitori in base alle rispettive sostanze e viene ad esistenza per il solo fatto di avere generato la prole (a prescindere dall’avere contratto matrimonio e indipendentemente dalle unioni civili e/o di fatto).
Volendo accennare, invece, agli altri provvedimenti riguardanti la prole, si farà qui cenno alla disciplina dell’affidamento dei figli (minorenni) contenuta nel Codice Civile agli articoli 337 ter e quater, che trova applicazione nei casi di separazione e divorzio, oltre che nei casi di annullamento/nullità del matrimonio e, parimenti, nei procedimenti che riguardano i figli nati fuori dal matrimonio.
In virtù della citata disciplina, è diritto dei figli essere mantenuti, educati, curati, istruiti e assistiti materialmente e moralmente da ciascuno dei genitori, nel rispetto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della persona. È diritto dei figli, inoltre, crescere in famiglia e mantenere stabili rapporti con tutti i membri della famiglia anche (e soprattutto) durante le delicate fasi della crisi coniugale e successivamente alla separazione e al divorzio, così l’art. 315 bis c.1. del Codice Civile.

La citata norma sancisce il più importante principio della bigenitorialità, il più evoluto fondamento del diritto di famiglia, secondo il quale la responsabilità genitoriale deve essere esercitata da entrambi i genitori dai quali l’Ordinamento italiano esige, a prescindere dalla crisi coniugale e dalle difficoltà di comporla, un imprescindibile minimum di cooperazione nell’interesse superiore della prole al fine di preservare, in favore dei figli – e seppure parzialmente rispetto alle condizioni precedenti di unità familiare – stabilità nelle relazioni affettive genitoriali e familiari, attraverso uno sforzo collaborativo tra i genitori, una linea progettuale e organizzativa nella crescita dei figli, nella cura e nell’assistenza morale e materiale della prole.
Il (relativamente recente) principio della bigenitorialità – non più “patria potestà”, né “potestà dei genitori” – e i contenuti in cui esso si concreta meritano ben più lunga riflessione cosicché, qui, se fa soltanto cenno, per lasciare spazio alla primissima domanda che i coniugi in procinto di separarsi pongono al proprio avvocato e che riguarda, appunto, l’affidamento dei figli della coppia.
Quando due genitori in procinto di separarsi si rivolgono all’avvocato civilista che si occupa quindi, tra l’altro, anche di diritto di famiglia, la domanda è (apparentemente) semplice: “Avvocato, in caso di separazione, a chi vengono affidati i bambini?”. La risposta si articola in due punti:
L’affidamento dei figli viene stabilito, di regola, in condivisione tra i genitori secondo l’art. 337 ter co.2 del Codice Civile: “Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati [omissis]”.

L’affidamento condiviso dei figli, pur essendo preferibile e di regola previsto dal Giudice, viene escluso, invece, qualora esso, nella concreta fattispecie, non sia nell’interesse del minore. L’affidamento esclusivo al genitore ritenuto più idoneo viene disposto dal Giudice all’esito di procedimento contenzioso davanti al Tribunale con provvedimento motivato. Più raro, ma non vietato in via di principio, è il caso in cui l’affidamento esclusivo dei figli venga previsto per accordo dai genitori entro la procedura di separazione consensuale o di divorzio congiunto. Si precisa che, in questo caso, i coniugi dovranno motivare specificamente sul punto per consentire il vaglio del Giudice in sede di Omologa o di Sentenza.

Sebbene l’affidamento condiviso dei figli sia la soluzione preferibile in caso di separazione e/o divorzio, nei casi in cui ciò non corrisponda all’interesse del minore, si opterà necessariamente per l’affidamento dei figli a un solo genitore (cosiddetto “affidamento esclusivo”), ovverosia a quello dei due ritenuto più idoneo.
I figli minorenni, infatti, saranno affidati a un solo genitore nel caso in cui la conflittualità sia tale da pregiudicare gli interessi del minore, nonché nei casi in cui un genitore non sia ritenuto idoneo alla cura dei minori.
La casistica per lo più comprende fattispecie in cui un genitore abbia usato violenza nei confronti dell’altro alla presenza dei figli, oltre che i casi di condotta violenta di un genitore verso i figli stessi. Poi, vari sono i precedenti della giurisprudenza di casi in cui un genitore abbia mostrato gravi carenze educative che, nella singola fattispecie, hanno indotto i Giudici a disporre l’affidamento esclusivo della prole all’altro genitore. Senza volere essere esaustivi, alcuni esempi: è stato disposto l’affidamento esclusivo dei figli nel caso di un genitore discontinuo nell’esercizio del diritto di incontro/visita; nel caso di un genitore che tiene sistematicamente comportamenti atti ad allontanare affettivamente/emotivamente il minore dall’altro genitore e/o che impedisce la frequentazione genitore/figlio. Vi sono, poi, i casi in cui è il figlio che chiede di non incontrare uno dei genitori.
Anche in caso di affidamento esclusivo, il Giudice applicherà, per quanto possibile in base alle circostanze concrete, il citato art 337-ter e adotterà i più opportuni provvedimenti affinché sia garantito, compatibilmente con la fattispecie concreta, il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori (e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, oltre che conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale).
Infine, un’ipotesi ancor più residuale prevede l’affidamento dei figli, o a parenti e istituzioni, in caso di impossibilità temporanea di affidare il minore a un genitore. Si tratta di provvedimenti che il Giudice può adottare per ragioni di eccezionale gravità, come extrema ratio, cioè quando vi è alto rischio che i genitori per fatto/condotta propria e/o per altre contingenze di fatto, possano arrecare pregiudizio per il minore.
Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini, per approfondimenti in materia di separazione e divorzio e, in special modo, per chiarimenti sulla possibilità di richiedere affidamento esclusivo dei figli minorenni, nonché, in generale, per una prima consulenza sul Vs. caso riceve, soltanto previo appuntamento, ai recapiti indicati (i riferimenti sono nella sezione contatti).
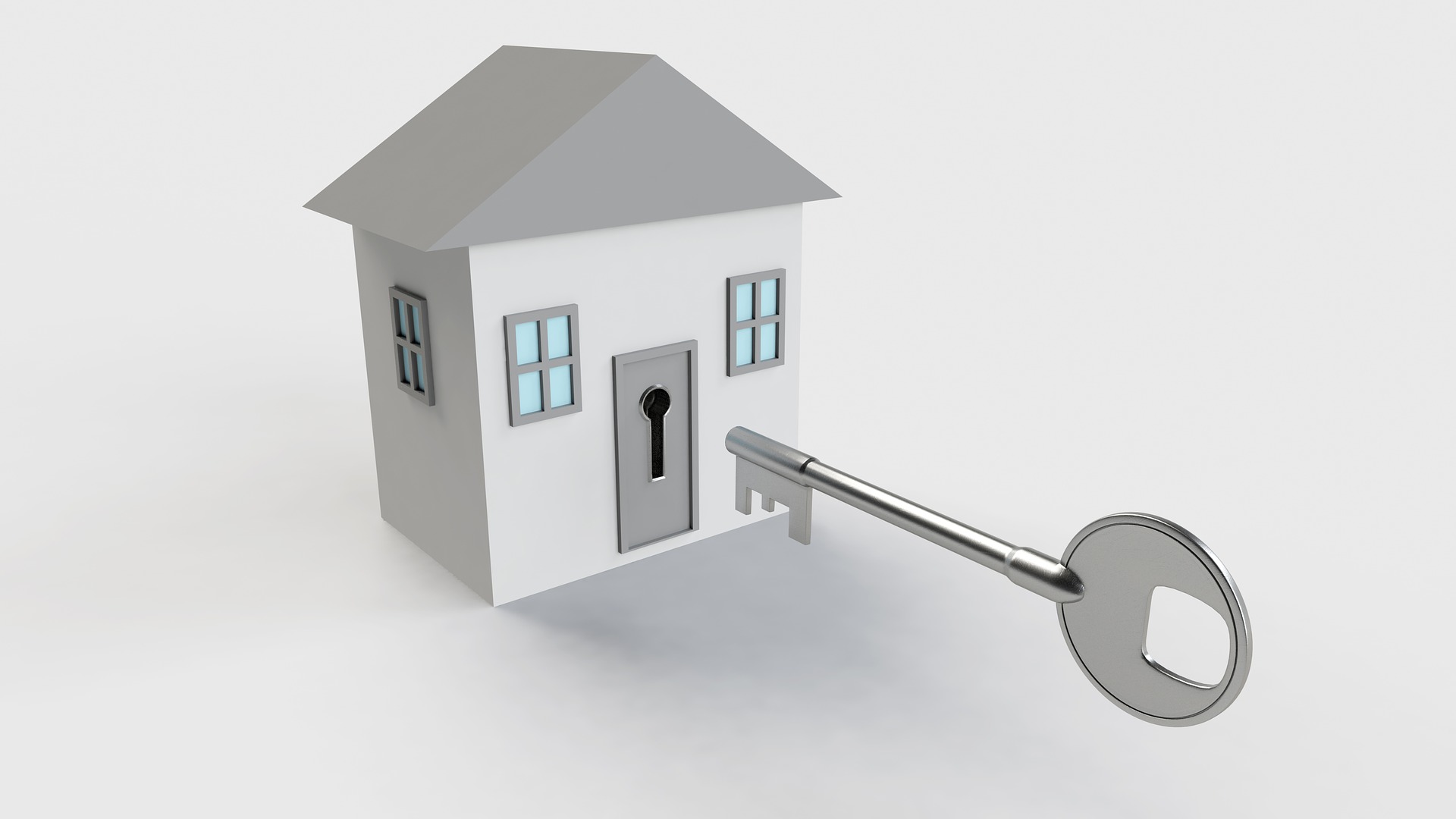
Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Vinci- Sovigliana, in località prossima al Comune di Capraia e Limite ed è raggiungibile in pochi minuti, anche a piedi, anche dal centro storico di Empoli. Nel proprio Studio Legale l’Avv. Chiara Pollini si occupa prevalentemente di questioni di diritto civile e di diritto di famiglia, materie in cui l’Avv. Chiara Pollini si è formata professionalmente e in cui si aggiorna con continuità.
Nell’ambito del diritto di famiglia, quando gli assistiti si rivolgono allo studio legale di propria fiducia in procinto di affrontare la separazione personale dal coniuge, oppure per chiedere il divorzio, la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi rappresenta uno dei punti focali della controversia.

Oggetto di contesa sono, tra gli altri beni, la casa familiare e/o le altre proprietà immobiliari (e/o i diritti reali su beni immobili) la cui attribuzione e/o assegnazione può essere decisa per accordo dai medesimi coniugi in caso di separazione consensuale e di divorzio congiunto. Soltanto in caso di disaccordo, invece, sarà il Giudice (su domanda di parte) a decidere in merito alla proprietà e agli altri diritti sugli immobili, all’esito del procedimento di separazione giudiziale o di divorzio giudiziale.
In altri articoli del blog si è fatto cenno alle ragioni per le quali, quando possibile, sono preferibili le soluzioni concordate della crisi coniugale, in via di separazione consensuale e di divorzio congiunto, oppure ricorrendo all’ulteriore strumento della procedura di negoziazione assistita. Una di queste ragioni riguarda i trasferimenti immobiliari che, entro l’ambito delle soluzioni concordate della crisi coniugale, i coniugi possono prevedere a favore di uno di essi o a favore dei figli, anche senza la previsione di un corrispettivo.
Per tale via, infatti, i coniugi giungono alla sistemazione del proprio patrimonio immobiliare in tempi molto più celeri rispetto a quelli che richiederebbe una causa di separazione o di divorzio giudiziale e, soprattutto, senza l’alea che caratterizza necessariamente ogni procedimento contenzioso. Il tutto, conseguendo anche vantaggi fiscali.
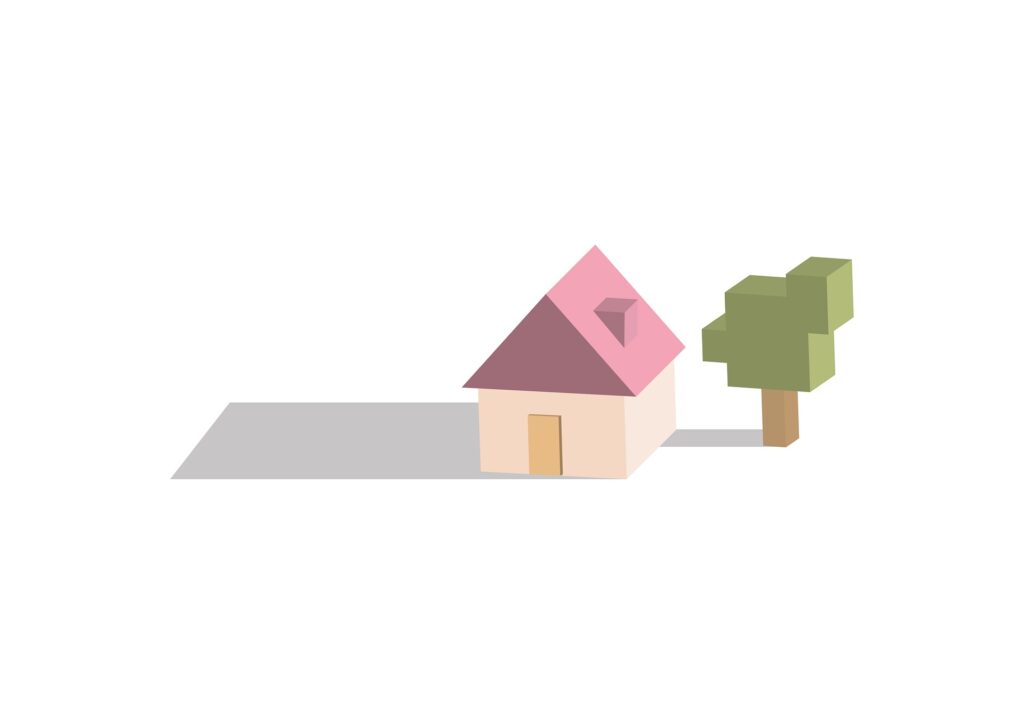
I coniugi possono accordarsi per trasferire da uno all’altro la proprietà esclusiva di un immobile (la casa familiare o altra abitazione, fondo, terreno e/o quant’altro), ovvero cedere reciprocamente le quote di proprietà su immobili, così come costituire diritti reali su immobili a loro favore (uso, abitazione, usufrutto), oppure prevedere il trasferimento o la costituzione di diritti reali in favore dei figli.

Nella prassi, più spesso, con la separazione consensuale o con il divorzio congiunto (analogamente con la negoziazione assistita), le predette operazioni immobiliari vengono preliminarmente promesse da un coniuge all’altro, con conseguente obbligo di concluderle entro un certo termine. Precisamente, nell’atto introduttivo del giudizio, le parti assumono l’impegno al trasferimento immobiliare che si realizzerà, davanti al Notaio, in un momento successivo alla separazione (o al divorzio) concordato dalle parti stesse.
In tal caso, ferme le agevolazioni fiscali, le parti dovranno comunque recarsi davanti al Notaio di loro fiducia per il trasferimento della proprietà.

Meno frequente, almeno per il momento, ma ben possibile, è l’immediato trasferimento immobiliare da un coniuge all’altro, o in favore dei figli, previsto già nel ricorso consensuale (quindi dandone, eventualmente, atto nel verbale di udienza di separazione o di udienza di divorzio davanti al Giudice). L’efficacia di questo tipo di accordo di trasferimento della proprietà sull’abitazione e/o sugli altri immobili dei coniugi è immediata nel senso che, di fatto, si concretizza necessariamente all’esito del procedimento di separazione (o divorzio) con il Decreto di Omologa adottato dal Tribunale, ovvero con la Sentenza di divorzio.
Se, in questo secondo peculiare caso, non è necessario l’intervento del Notaio, pur tuttavia si osserva, in linea generale, come la professionalità del Notaio offra le migliori garanzie ai coniugi affinché il trasferimento immobiliare sia immune dall’inizio da vizi di sorta, nonché ai fini della perfetta trascrizione nei pubblici registri immobiliari.
Il trasferimento immobiliare, infatti, è bene ricordarlo, può essere operazione molto complessa e che necessita di competenza interdisciplinare per i vari adempimenti di prassi; per tale motivo, a parere di Chi scrive, il Notaio resta la figura più adatta per la compilazione degli atti di trasferimento della proprietà e/o di costituzione dei diritti reali.
Tanto è vero che alcuni Tribunali hanno adottato protocolli specifici da seguire nel caso di accordi tra i coniugi aventi ad oggetto il trasferimento della casa familiare e degli altri immobili in sede di separazione o divorzio, onde istruire e compilare in maniera completa la parte dell’atto relativa al trasferimento.
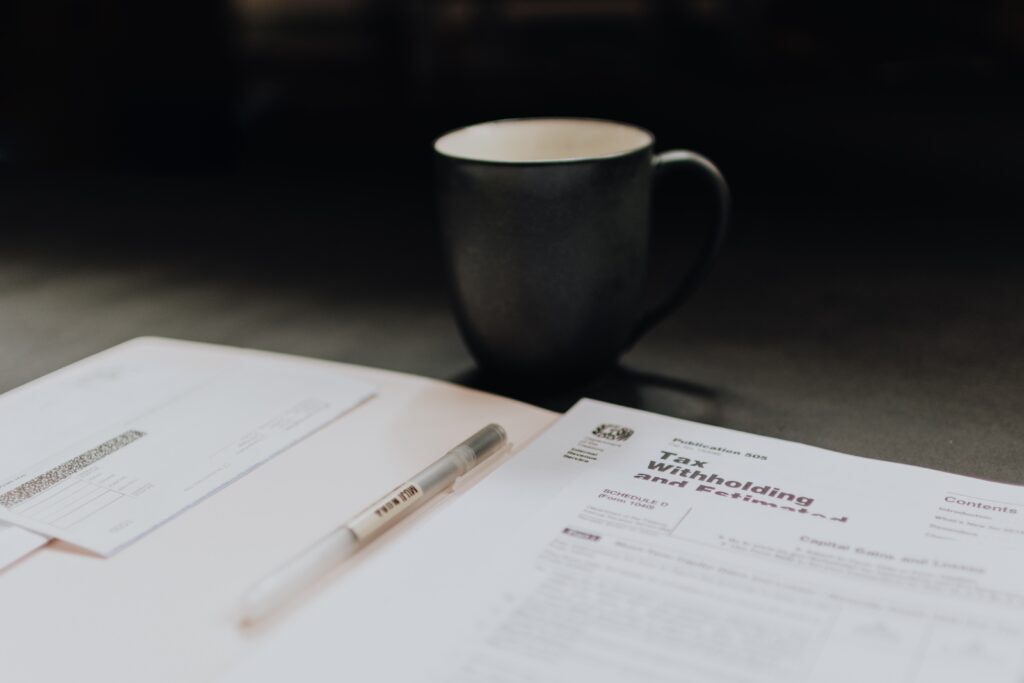
Il trattamento di favore del quale, nel nostro Ordinamento, godono questi accordi tra i coniugi risponde alla specifica finalità per la quale essi sono stipulati: la sistemazione dei rapporti economici della coppia come parte della soluzione del legame affettivo/familiare. Essi rappresentano, cioè, il modo attraverso cui i coniugi risolvono la crisi coniugale e ne costituiscono condizione peculiare del componimento. Questa finalità, riconosciuta dalla Giurisprudenza, distingue tali accordi di trasferimento dalle donazioni.
Tali accordi rispondono, di norma, ad un intento di sistemazione dei rapporti economici della coppia che sfugge, da un lato, alle connotazioni di una vera e propria donazione (di per sé estranea ad un contesto caratterizzato dalla dissoluzione delle ragioni dell’affettività), e dall’altro a quelle di un atto di vendita (non fosse altro che per l’assenza di un prezzo corrisposto), e svela, dunque, una sua tipicità, che può colorarsi dei tratti propri dell’onerosità o della gratuità a seconda che l’attribuzione trovi o meno giustificazione nel dovere di compensare e/o ripagare l’altro coniuge del compimento di una serie di atti a contenuto patrimoniale, anche solo riflesso, da questi posti in essere nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale.
[CASS. CIV., SEZ. I, SENTENZA, 10/04/2013, N. 8678]
L’attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale, in adempimento di una condizione inserita nell’atto di separazione consensuale, non costituisce una forma di alienazione dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici prima casa in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, bensì una forma di utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti tra coniugi, sia pure al venir meno della loro convivenza.
[Cass. civ., Sez. V, 13/11/2015, n. 23225]
Per una consulenza in materia di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, degli accordi di trasferimento immobiliare, in materia di separazione e divorzio e per altre questioni in materia di diritto di famiglia o di diritto civile, si invita a prendere un appuntamento in Studio.

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243
L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a meno di un chilometro dal centro città di Empoli ed è facilmente raggiungibile anche dal vicino Comune di Capraia-Limite e da Montelupo Fiorentino.
L’Avv. Chiara Pollini nel proprio Studio Legale si occupa prevalentemente di diritto civile, dedicandosi con continuità, tra l’altro, alle questioni che riguardano il diritto di famiglia.
Nell’ambito del diritto di famiglia, negli ultimi anni, presumibilmente a causa della crisi economica generale, si è tornati a sottoporre all’avvocato casi aventi ad oggetto la richiesta di alimenti, non soltanto da parte del coniuge all’altro coniuge, ma anche da parte di altri componenti del nucleo familiare tra loro (richiesta di alimenti di genitori ai figli, richiesta di alimenti tra fratelli e così via).

Possono chiedere gli alimenti i soggetti di cui all’art. 438 c.c.:
secondo un vero e proprio ordine gerarchico in base alla “vicinanza” del vincolo familiare. L’elenco dei soggetti obbligati a prestare gli alimenti è tassativo e l’alimentando si deve rivolgere all’obbligato più prossimo e, solo in caso di impossibilità di questi, procedere con gli obbligati di grado più remoto.
Vediamo, allora, a chi si può chiedere di prestare gli alimenti. Nell’ordine: al coniuge, ai figli, ai genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli/sorelle. Se il coniuge o i figli non ci sono e non ci sono neppure altri discendenti, oppure se essi non possono prestare gli alimenti, il familiare – che dimostri di essere in stato di bisogno – potrà rivolgere la domanda, in via subordinata, agli altri componenti della famiglia.

Il diritto agli alimenti è strettamente personale: legittimato a proporre la domanda al Giudice è colui che si trova in stato di bisogno, personalmente o tramite il proprio rappresentante legale. Ulteriore conseguenza è che l’obbligazione si estingue con la morte dell’avente diritto, nonché con la morte dell’obbligato al pagamento.
Il diritto agli alimenti è incedibile: di conseguenza, non sono ammissibili rinuncia (ma ovviamente è legittimo il mancato esercizio del diritto) né transazione. Esso è imprescrittibile (mentre si prescrivono in cinque anni le annualità scadute, a norma dell’ art. 2948, n. 2), impignorabile, tranne che per causa di alimenti (art. 545 c.p.c.) e quindi insequestrabile (art. 671 c.p.c.) e non entra nella massa fallimentare.
Tale contributo alla somministrazione di alimenti entro la famiglia – obbligo alimentare – è giuridicamente diverso e più limitato rispetto al concetto di “mantenimento” ricorrente nelle procedure di separazione e divorzio.
Infatti, chi è obbligato a pagare gli alimenti è tenuto a far fronte soltanto a quanto al familiare avente diritto è necessario per vivere. Chi è obbligato al mantenimento, invece – e l’obbligazione, come detto, rileva nelle controversie in materia di separazione e di divorzio, nei rapporti tra coniugi e nei rapporti tra genitori e figli – è obbligato a un contributo più ampio.
Il contributo al mantenimento del coniuge e/o dei figli corrisponde a una somma di denaro finalizzata a soddisfare tutte le esigenze di vita dell’avente diritto, a prescindere dallo stato di bisogno di quest’ultimo.Dei requisiti per la richiesta di assegno di mantenimento, nelle procedure di separazione e divorzio, consensuali o contenziose, si è già trattato in altri articoli del blog.
I presupposti oggettivi per l’esistenza del diritto agli alimenti sono lo stato di bisogno dell’avente diritto – e la conseguente incapacità di provvedere al proprio mantenimento – nonché la capacità economica dell’obbligato.
Il concetto di stato di bisogno, secondo l’opinione prevalente, va riferito alla mancanza dei mezzi necessari a soddisfare i bisogni primari dell’individuo: ciò si verifica non solo quando il soggetto è privo dei mezzi di sussistenza, ma anche quando manca di ciò che consente di condurre una vita dignitosa.
Si è detto che il diritto agli alimenti è diverso dal diritto al mantenimento del coniuge e dal diritto al mantenimento dei figli dato che, nelle controversie in materia di separazione e di divorzio e, in generale, nei rapporti tra genitori e figli, l’obbligazione al mantenimento ha un contenuto più ampio e completo rispetto all’obbligo di prestare gli alimenti in quanto è finalizzato a garantire le esigenze della vita della persona complessivamente considerate.

Infatti, qui detto in estrema sintesi, chi è obbligato a pagare gli alimenti ad un familiare in stato di bisogno è tenuto a far fronte soltanto a quanto all’avente diritto agli alimenti è necessario per vivere.
Così si è espressa la Corte di Cassazione nell’orientamento del 2013:
“Lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall’art. 438 cod. civ., esprime l’impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l’abitazione, il vestiario, le cure mediche e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell’alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie”.
Posto, dunque, che il diritto agli alimenti è limitato a garantire quanto necessario per vivere, considerando la posizione sociale dell’avente diritto, la pretesa dell’alimentando potrà essere soddisfatta, sia a mezzo il pagamento di una somma periodica, sia in maniera diretta, cioè accogliendo e mantenendo la persona che ne ha diritto presso l’abitazione dell’obbligato medesimo. Sarà il Giudice, a seconda delle concrete circostanze, a valutare e stabilire le modalità di somministrazione degli alimenti nel caso concreto, nell’esercizio del proprio potere discrezionale.

Chi versa in stato di bisogno dovrà rivolgersi al Tribunale e proporre azione giudiziale mirata al riconoscimento del proprio diritto. Chi versa in stato di bisogno potrà, ove ne ricorrano i requisiti di reddito, eventualmente richiedere di essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato per essere assisto da un avvocato, nella causa avente ad oggetto la domanda di pagamento degli alimenti, senza anticipare le spese legali (che, appunto, saranno pagate all’avvocato direttamente dallo Stato).
Nel proporre domanda di pagamento degli alimenti, ove secondo l’art. 433 c.c. citato vi siano più soggetti tenuti agli alimenti del medesimo grado di parentela, questi saranno dichiarati tutti obbligati verso il beneficiario, ma ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche (art. 411 primo comma c.c.).
Sarà il Giudice, in caso di disaccordo tra più coobbligati, a decidere sulla ripartizione del contributo e sulle concrete modalità di prestazione. Il soggetto coobbligato potrà opporsi fondatamente alla richiesta di pagamento di alimenti presentata da un familiare soltanto dimostrando al Giudice di non avere adeguate risorse per sostenere l’obbligo.
Ciò significa che, a fronte di una richiesta di alimenti avanzata, per fare un esempio, da un genitore ai figli, i figli saranno entrambi dichiarati obbligati dal Giudice, ma ciascuno in base alla concreta possibilità di farvi fronte, dovendo valutarsi e compararsi la rispettiva capacità patrimoniale dei figli.
Nel corso del tempo, la prestazione alimentare può essere soggetta a variazioni in base ai requisiti di legge: cioè, se varia la condizione di stato di bisogno del beneficiario e/o se cambiano le possibilità economiche dell’obbligato. Può quindi essere aumentata, ridotta o cessare per decisione del giudice, sempre su istanza della parte interessata.
L’obbligazione alimentare può estinguersi per vari motivi:
Si ricorda anche che violare l’obbligo di assistenza familiare può integrare condotta di reato. Infatti, ai sensi dell’art. 570 II comma, n.2 c.p. è specificamente punita l’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, o inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato.
I casi concreti sono vari e molteplici. Ad esempio, l’assegno alimentare può essere disposto dal Giudice come obbligazione in capo ai genitori verso i figli maggiorenni, magari non più conviventi, quando questi ultimi sono disoccupati e, anche in età più matura, incapaci per comprovati motivi di trovare lavoro. Oppure, ancora a titolo puramente esemplificativo, possono crearsi veri e proprio conflitti tra fratelli (o nipoti) su chi debba farsi carico di un genitore (o di uno zio) e su chi – e in quale misura – debba sostenere le relative spese di eventuali badanti o strutture di degenza.
In casi come questi, potrebbe essere opportuno rivolgersi ad un legale per conoscere quali sono i familiari obbligati a pagare gli alimenti e in che modo e misura possono essere eventualmente obbligati a somministrarli all’avente diritto.
Per una consulenza specifica sulla possibilità di chiedere gli alimenti ex art. 433 c.c., o sull’obbligo di pagare il contributo alimentare in favore di un familiare e, in generale, per altre questioni in materia di diritto di famiglia o di diritto civile, si invita a prendere un appuntamento in Studio.

L’Avv. Chiara Pollini, titolare del proprio Studio Legale a Vinci (Firenze), a pochi passi dal centro città di Empoli, è avvocato civilista con consolidata esperienza, tra l’altro, in materia di responsabilità civile e in materia di risarcimento danni da infortuni.
Tra gli infortuni risarcibili che possono rendere necessaria la consulenza dell’avvocato civilista (oltre ai più comuni casi di sinistro stradale), tutt’altro che infrequenti sono gli infortuni sulla neve, verificatisi sulle piste da sci e/o all’interno degli impianti sciistici.

Prima di affrontare gli aspetti della responsabilità civile (e valutare eventualmente la sussistenza di profili di responsabilità penale), come detto anche in precedenti articoli del blog, si ricorda che da Gennaio 2022 (con il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40) è in vigore l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile per gli utenti delle piste da sci alpino per danni e infortuni causati a terzi (art.30). È infatti previsto sulle piste da sci il concorso di responsabilità degli utenti e
“Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi” (art.28).
Ciò premesso, per superare la presunzione del concorso di colpa, l’individuazione della responsabilità ai fini del risarcimento danni riportati dallo sciatore è legata alla specifica causa dell’incidente concretamente verificatosi sulla neve.
I sinistri sulla neve che si presentano più comunemente vedono, oltre i casi di scontro tra sciatori e/o altri praticanti attività sportive all’interno degli impianti sciistici, le cadute dello sciatore causate da non corretta manutenzione della pista da sci, ovvero causate da collisione con ostacolo non segnalato presente all’interno dell’impianto. Da tali fattispecie, inoltre, possono ovviamente derivare direttamente o indirettamente danni a terzi.

La casistica degli incidenti sulla neve, quindi, anche limitandosi a considerare le fattispecie più comuni, contempla necessariamente molteplici fattori nel processo di determinazione causale e ciascun fattore ben più avere una diversa incidenza ai fini della responsabilità dei danni occorsi. Da quanto pur sommariamente esemplificato, si comprende come istruire una causa in materia di risarcimento danni per un incidente sulla neve possa rivelarsi complesso.
Lo sciatore danneggiato, infatti, davanti al Giudice dovrà provare il nesso di causa/effetto tra il danno riportato e la condotta del gestore dell’impianto, prima e la quantificazione del danno riportato, poi. Il gestore dell’impianto, invece, è onerato della prova liberatoria rappresentata dall’eventuale condotta dello sciatore. Il comportamento dello sciatore esimente della responsabilità del gestore potrà avere efficienza causale esclusiva e rilevare quale caso fortuito (ex art. 2051 c.c.), oppure concorrente, quindi non esclusiva e rilevare comunque quale fatto colposo concorrente (ex art. 1227 c.c., comma 1) con la responsabilità del titolare/custode della pista da sci.

Ad esempio, in caso incidente verificatosi sulla pista da sci in cui lo sciatore domanda il risarcimento del danno al gestore o al proprietario dell’impianto per aver impattato in un ostacolo, è probabile che la società che ha in custodia l’impianto sciistico a propria difesa sostenga, a vario titolo, la corresponsabilità dello sciatore (condotta imprudente, velocità inadeguata alle caratteristiche della pista, oppure violazione regolamenti ecc..) nel tentativo di fornire la prova liberatoria della propria responsabilità.
Tuttavia, quando il sinistro sulla pista da sci – la caduta dello sciatore – è causato da un ostacolo atipico, definito dal citato D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 come il “pericolo difficilmente evitabile anche per uno sciatore o sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico” (art. 2, comma 1, lett. d), il danneggiato ha diritto a vedere il danno patito risarcito integralmente.
Nell’istruire la causa, quindi, per poter ottenere il risarcimento integrale dei danni, lo sciatore, con riguardo alla causa della caduta, dovrà fornire prova dell’atipicità dell’ostacolo trovato sulla pista, “atipicità” che – ricorda la Corte di Cassazione (con Ordinanza, 19/05/2022, n. 16223) è concetto consolidato già nell’elaborazione giurisprudenziale della L. 24 dicembre 2003, n. 363, art. 7, comma 2 ove “la nozione di “pericolo atipico” era stata riscostruita sulla base di due criteri: quello, oggettivo, della normalità e visibilità e quello, soggettivo, della prevedibilità ed evitabilità da parte dello sciatore responsabile e, ciò, ancora prima del recentissimo citato D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40”.
Afferma, infatti, nella predetta recente Pronuncia la Corte di Cassazione: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. del gestore di piste da sci alpino presuppone la sussistenza di un nesso causale tra la caduta dello sciatore danneggiato e la presenza di un pericolo “atipico” sulla pista, da intendersi come ostacolo difficilmente visibile e, pertanto, non facilmente evitabile anche da parte di uno sciatore diligente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto responsabile il gestore per la caduta di uno sciatore, provocata dalla presenza di un accumulo di neve derivante da innevamento artificiale, scarsamente visibile e di rilevanti dimensioni, tale da impegnare una parte considerevole della pista e, pertanto, non riconducibile al normale utilizzo della stessa)”. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/05/2022, n. 16223 (rv. 664901-01).

In caso di incidente sulla neve, per un parere legale sul diritto a presentare domanda di risarcimento danni alla società che gestisce l’impianto sciistico, oppure per una consulenza sulla richiesta risarcitoria nei confronti delle altre persone coinvolte in caso di “incidente sugli sci”, si invita a prendere un appuntamento in Studio ai contatti indicati.
*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

L’Avv. Chiara Pollini svolge l’attività nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Vinci, dove si occupa di diritto civile e di diritto di famiglia.
Nell’ambito della materia del diritto di famiglia, lo Studio assistite i propri clienti nei procedimenti di separazione e di divorzio, fornendo la propria consulenza nell’arco di tutte le fasi della crisi coniugale.
In caso di richiesta di divorzio (così come per la separazione dei coniugi), pur prediligendosi soluzioni concertate della crisi familiare – separazione consensuale, divorzio congiunto e, non ultima, la procedura di negoziazione assistita – ove non sia possibile raggiungere alcun accordo, viene avviato il procedimento contenzioso di scioglimento del matrimonio o quello di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanti il Tribunale.

La Legge sul divorzio Nr. 898/70 prevede, che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale disponga l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro che non ha mezzi adeguati – o comunque che non può procurarseli per ragioni oggettive – previa valutazione:
e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.

La Giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di assegno divorzile, nei decenni molto vasta, è addivenuta recentemente ad una rinnovata interpretazione della disciplina citata, con la nota pronuncia a Sezioni Unite Nr. 18287 del 11 Luglio 2018.
In materia di assegno divorzile, con tale sentenza viene abbandonata l’interpretazione che fondava il riconoscimento dell’assegno di divorzio sul diritto per il coniuge richiedente di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
A tale orientamento, è subentrata una lettura della legge costituzionalmente orientata ai principi di pari dignità e solidarietà tra le parti, il cui fulcro è – certamente – l’analisi della complessiva situazione reddituale/patrimoniale di ciascuna parte che viene, non soltanto confrontata con quella dell’altra parte, in quanto condizione economica effettiva e attuale, ma valutata anche nel suo potenziale (le possibilità del coniuge di procurarsi mezzi adeguati di cui alla Legge Nr. 898/70).
Infatti, secondo il nuovo orientamento della Corte di Cassazione in materia di diritto all’assegno divorzile, affinché l’assegno venga riconosciuto al coniuge che ne fa richiesta – e quantificato nella misura in cui è domandato nella singola fattispecie – assolvendo alla funzione (anche) assistenziale, oltre che perequativa, riequilibratrice e risarcitoria a tutela della parte economicamente più debole.
Posta la fondamentale importanza di approfondito esame delle posizioni economiche dei coniugi, il Tribunale, affinché possa essere dichiarata l’esistenza del diritto all’assegno divorzile (e per quantificare l’importo), dovrà mettere in relazione la disamina predetta con gli altri parametri previsti dalla legge di divorzio.
Si riporta un passo della citata fondamentale pronuncia: “Ai fini del riconoscimento dell’assegno si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale”.
La Giurisprudenza a Sezioni Unite fornisce, quindi, una chiave di lettura della norma che getta luce sulle ragioni che – lungo la durata del matrimonio – hanno causato e/o concausato la differenza patrimoniale e reddituale dei coniugi che residua alla fine del matrimonio, cosicché il diritto all’assegno di divorzio risponda alla rinnovata funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa.
Dopo la pronuncia a Sezioni Unite, quindi, la Giurisprudenza delle più recenti pronunce fornisce applicazioni del nuovo orientamento univoche, tra cui la recente Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 22/09/2022, n. 27753 da cui è estratta la trascritta massima “Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della L., n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto” .
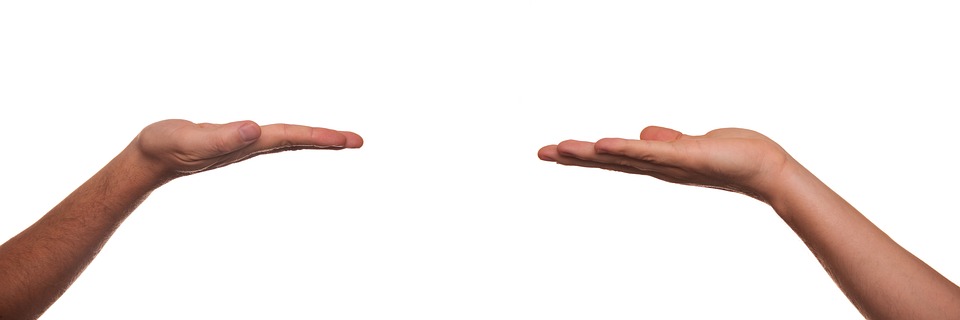
A mente del dettato normativo e ricordato il nuovo Orientamento delle Sezioni Unite, il coniuge che avvii una procedura di divorzio contenzioso per vedere accolta, tra le altre richieste del divorzio, l’istanza di assegno divorzile dovrà dettagliare e provare al Giudice i propri redditi e l’inferiorità complessiva della propria posizione economica rispetto a quella della controparte e, allo stesso tempo, fornire prova dell’impegno profuso – nel corso del matrimonio – nell’organizzazione della vita familiare e l’apporto fornito alla formazione del patrimonio familiare e delle conseguenze che ciò ha importato sulla condizione economica medesima.
Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova nella frazione di Sovigliana-Vinci, raggiungibile in pochi minuti anche dal confinante centro città di Empoli e dai limitrofi Comuni di Capraia-Limite e Montelupo Fiorentino.
Per una consulenza in materia di divorzio e approfondimenti sulla opportunità di richiedere l’assegno divorzile (o la sua revisione) e, in ogni caso, per una valutazione del Vs. caso concreto, lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini riceve previo appuntamento ai recapiti indicati.

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Vinci.
Lo Studio Legale si trova nella frazione di Sovigliana, raggiungibile in pochi passi anche dal centro storico di Empoli e si occupa prevalentemente di diritto civile e di diritto di famiglia, quindi anche dei procedimenti di separazione e divorzio.
Nella gestione legale della crisi coniugale gli interessi da curare sono molti e diversificati tra loro e, tra questi, il mantenimento dei figli rappresenta, forse, la maggiore preoccupazione del genitore in procinto di separarsi (o di divorziare).
Come detto in un precedente articolo del blog,
l’obbligo di mantenimento dei figli è previsto a carico dei genitori dalla Costituzione (art.30) e vale per il solo fatto di averli generati, a prescindere dall’avere contratto matrimonio e indipendentemente dalle unioni civili e/o di fatto e sussiste per entrambi i genitori in base alle rispettive sostanze.

Il riferimento alle rispettive condizioni economiche dei genitori è contenuto, insieme agli altri criteri per quantificare l’assegno, nel codice civile (art. 337 ter co.4) che espressamente dispone:
“Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.”

La logica sottesa ai cinque criteri indicati dal Codice Civile risponde all’obiettivo di preservare e/o perseguire tendenzialmente una soglia di continuità e stabilità economica per la prole, mirando ad evitare, per quanto possibile nel caso concreto, che dalla separazione (o dal divorzio) dei genitori, derivi un pregiudizio nella formazione e nella crescita dei figli. Infatti, il nostro Ordinamento, almeno in linea di principio, mira a mantenere inalterato il tenore di vita goduto dai figli prima e dopo la crisi coniugale, nel superiore interesse della prole.
Per tale motivo, nel decidere l’importo del mantenimento per i figli, il Giudice dovrà valutare prioritariamente le esigenze della prole complessivamente considerate (scolastiche e/o di avviamento professionale, ma anche ludiche o di svago, così come esigenze di sostegno di altra natura, psicofisica, sanitaria… e via dicendo) nell’ottica delle adeguate pretese dei genitori.

Nelle disparate fattispecie concrete, il criterio-guida della conservazione del tenore di vita tenuto dai figli prima della separazione dei genitori viene variamente contemperato dai Giudici e contestualizzato con l’oggettivo impoverimento dei coniugi che solitamente consegue la cessazione della convivenza, la cessazione della condivisione della vita e delle risorse economiche.
La Legge, dunque, impone ai genitori di continuare a garantire il soddisfacimento delle necessità di cura e assistenza morale e materiale, considerando il tenore e lo stile di vita goduto dalla prole in costanza di convivenza.
Al contempo, però, il Codice Civile dispone anche che si tenga specificamente conto della misura in cui ciascuno dei genitori – cessata, appunto, la convivenza e la vita in comune – è in grado di contribuire al mantenimento dei figli in ragione della mutata situazione economica.
Inoltre, il Giudice deve tenere conto, in questa complessa valutazione della quantificazione dell’assegno mensile di mantenimento, anche dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
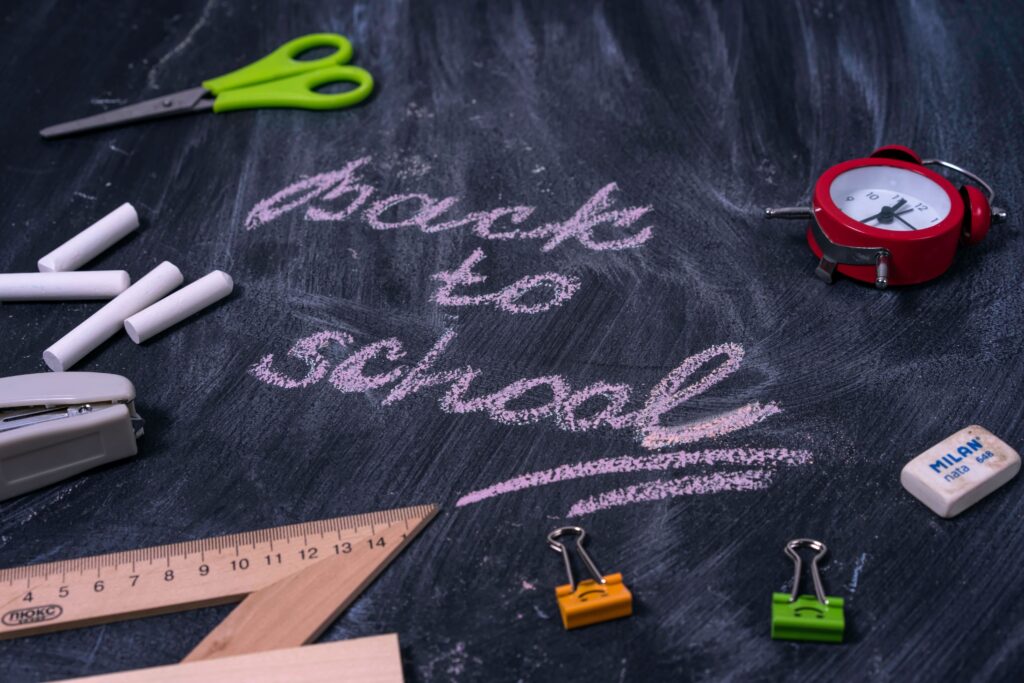
Correlato alla valutazione del tempo di permanenza presso ciascun genitore, è l’ultimo criterio indicato dal Codice Civile per quantificare l’assegno di mantenimento dei figli: la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Questo criterio è finalizzato a valorizzare l’impegno personale genitoriale concretamente profuso nella quotidianità per i figli, cioè ad attribuire peso economico al tempo e allo sforzo che ciascun genitore dedica alle normali necessità (più disparate) dei figli.
Nella pratica, ovviamente l’impegno profuso da ciascun genitore nel “seguire” i figli non è agevolmente monetizzabile, tuttavia i Giudici tendono a valorizzare l’importanza nell’articolata complessiva valutazione finalizzata al calcolo dell’assegno.

Il criterio più rilevante nella quantificazione dell’assegno di mantenimento mensile a carico del genitore tenuto a pagare, come inizialmente anticipato, non può che essere quello prettamente patrimoniale: la comparazione dei redditi dei genitori, redditi che vengono portati all’attenzione del Giudice da qualunque fonte essi provengano.
L’eventuale sopraggiunta variazione delle condizioni economiche (in peggio o in meglio) può, infatti, dare diritto a revisione dell’assegno mensile come precedentemente quantificato in favore dei figli.
L’importo dell’assegno mensile stabilito concordemente per il mantenimento dei figli in caso di separazione consensuale (o divorzio congiunto), ovvero quello indicato dal Tribunale, è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT senza che sia necessaria la messa in mora da parte del creditore (l’adeguamento è, infatti, automatico).
Posti i criteri indicati dalla Legge nella determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento dei figli, è importante ricordare che ogni caso della vita è diverso e che, pertanto, ogni fattispecie concreta che coinvolge il Cliente necessita di essere approfondita per poter indicare le più opportune tutele dei diritti e degli interessi concretamente esistenti.
Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini, per approfondimenti sull’obbligo di concorso nel mantenimento dei figli, sull’esistenza dei requisiti per la revisione o la cessazione dell’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento e per una valutazione del Vs. caso concreto, riceve previo appuntamento ai recapiti indicati nella sezione dei contatti.

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa di diritto civile e di diritto di famiglia e, in questo ambito, per i procedimenti di separazione (o divorzio) dei coniugi, anche di Negoziazione Assistita.
La crisi coniugale può risolversi trovando un accordo tra le parti, non più soltanto con la separazione consensuale (o con il divorzio congiunto), ma anche in via stragiudiziale con lo strumento che, con linguaggio tanto improprio quanto d’effetto, è comunemente conosciuto come “separazione tramite avvocati” in quanto non è necessario adire il Tribunale.
I coniugi possono separarsi consensualmente – chiedere la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio e/o divorziare – senza ricorrere al Giudice, attraverso lo strumento introdotto nel nostro Ordinamento con D.L. 132/2014, conv. Legge 162/2014: la Convenzione di Negoziazione assistita con l’assistenza degli avvocati.
La procedura prevede obbligatoriamente l’assistenza di almeno un avvocato per ciascun coniuge e si articola in due fasi principali:
la redazione/sottoscrizione della Convenzione di Negoziazione e la conclusione/sottoscrizione dell’Accordo di Negoziazione.
Il coniuge che ha deciso di separarsi (o divorziare) invierà – tramite il proprio avvocato – un invito formale all’altro coniuge alla stipula della Convenzione di Negoziazione, cui seguirà, in caso di accettazione da parte del coniuge destinatario, l’avvio della procedura stragiudiziale.
Nel caso in cui il coniuge destinatario rifiuti l’invito ad aderire alla procedura, il coniuge che ha preso l’iniziativa non potrà fare altro che ricorrere alla via giudiziale e rivolgersi al Tribunale.

Sul presupposto, invece, che l’interesse alla separazione (divorzio) consensuale “davanti agli avvocati” sia condiviso e l’invito venga accettato, si avvia il procedimento.

La prima fase prevede che venga redatta dagli avvocati la Convezione di Negoziazione, in vigenza della quale i coniugi cercheranno, aiutati dai rispettivi avvocati, di giungere all’accordo di separazione (divorzio) vero e proprio.
Si tratta di una convenzione/contratto tra i coniugi con il quale, tra l’altro, le parti si obbligano a cooperare tra loro in buona fede e con lealtà per risolvere bonariamente la controversia e raggiungere comunanza di intenti sulle condizioni di separazione/divorzio.
Fondamentale è l’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite dalle parti in questa fase: la Convenzione di Negoziazione vieta, infatti, alle parti (e specificamente anche i rispettivi avvocati) di divulgare e/o utilizzare in un eventuale giudizio avente il medesimo oggetto le notizie apprese nel corso della procedura.
Nella Convenzione di Negoziazione sono indicati i tempi della procedura che non possono essere inferiori a un mese e che non devono protrarsi oltre i quattro mesi.
Entro questo periodo, tramite il confronto e la collaborazione dei rispettivi avvocati nel quadro della disciplina indicata dalla Convenzione di Negoziazione, le parti cercano di avvicinare le loro divergenze e trovare l’auspicato accordo.
In questa fase, come accade per la separazione consensuale avanti il Tribunale (o per il divorzio congiunto), vengono esaminati tutti gli aspetti dei rapporti tra i coniugi, tra i genitori, tra genitori e figli e ogni questione economica e patrimoniale che necessiti di essere regolata.
È questa la delicatissima fase di confronto e di conciliazione delle richieste e delle posizioni dei coniugi in cui devono valutarsi gli opposti interessi, trovando una soluzione conciliativa che soddisfi entrambe le parti.

Se le parti giungono ad un accordo nel termine previsto nella Convenzione di Negoziazione, gli avvocati redigono il Verbale di Negoziazione Assistita che, finalmente sottoscritto dai coniugi, conterrà le condizioni vere e proprie dell’accordo di separazione (o divorzio).
Il verbale sarà trasmesso, nel termine di dieci giorni dalla data di conclusione, al Procuratore della Repubblica (P.M.) presso il Tribunale competente per la verifica della regolarità e dei contenuti e, quindi, per ricevere autorizzazione e/o nulla osta (soltanto successivamente, l’accordo sarà trasmesso anche all’Ufficio dello Stato Civile del Comune per le necessarie annotazioni).
Nel caso in cui il P.M. non ritenga di poter rilasciare autorizzazione (o nulla osta, a seconda che siano, o non siano, coinvolti interessi anche di figli minorenni della coppia o maggiorenni non indipendenti economicamente), trasmetterà il verbale al Presidente del Tribunale.
Il Presidente del Tribunale, entro cinque giorni successivi, fissa la comparizione delle parti avanti a Sé, aprendosi una terza fase che, a seconda dei casi, potrà condurre alla definitiva autorizzazione dell’accordo o, invece, al diniego da parte del Presidente.
La procedura per separarsi (o divorziare) senza dover ricorrere al Tribunale è qui descritta in maniera sintetica e senza pretesa di essere esaustiva, ma, si crede, è già sintesi da cui si comprende la snellezza della procedura e le brevità delle tempistiche.
È senz’altro uno strumento di soluzione stragiudiziale della crisi coniugale di grande utilità che importa oneri minori, per tempi e costi.
Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini offre la propria consulenza per la valutazione della possibilità di ricorrere alla procedura della Convenzione di Negoziazione Assistita per la separazione dal coniuge (o per modificare le condizioni di separazione o per il divorzio) e, in generale, per valutare la possibilità di risolvere consensualmente la crisi coniugale.
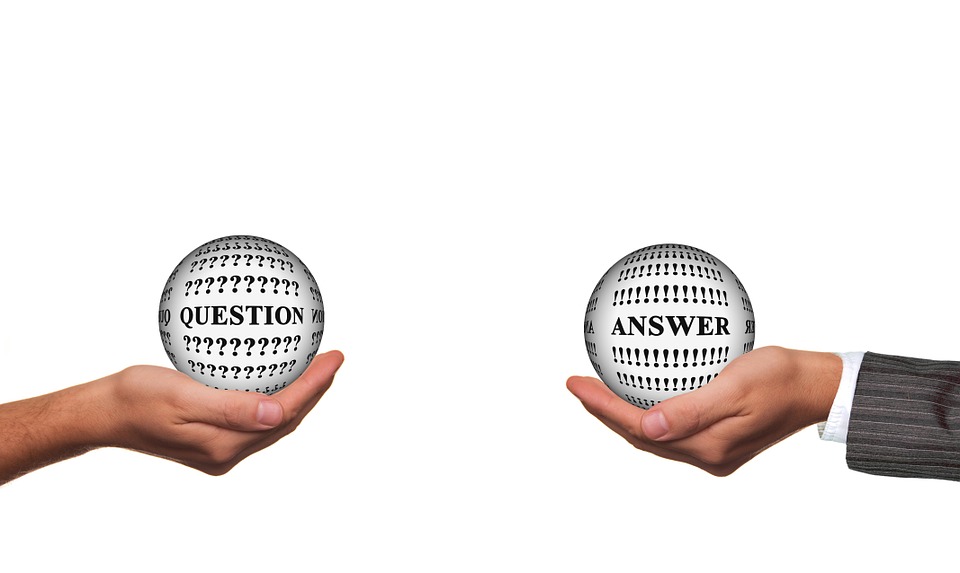
Si ricorda che lo Studio riceve previo appuntamento ai recapiti indicati nella sezione contatti.